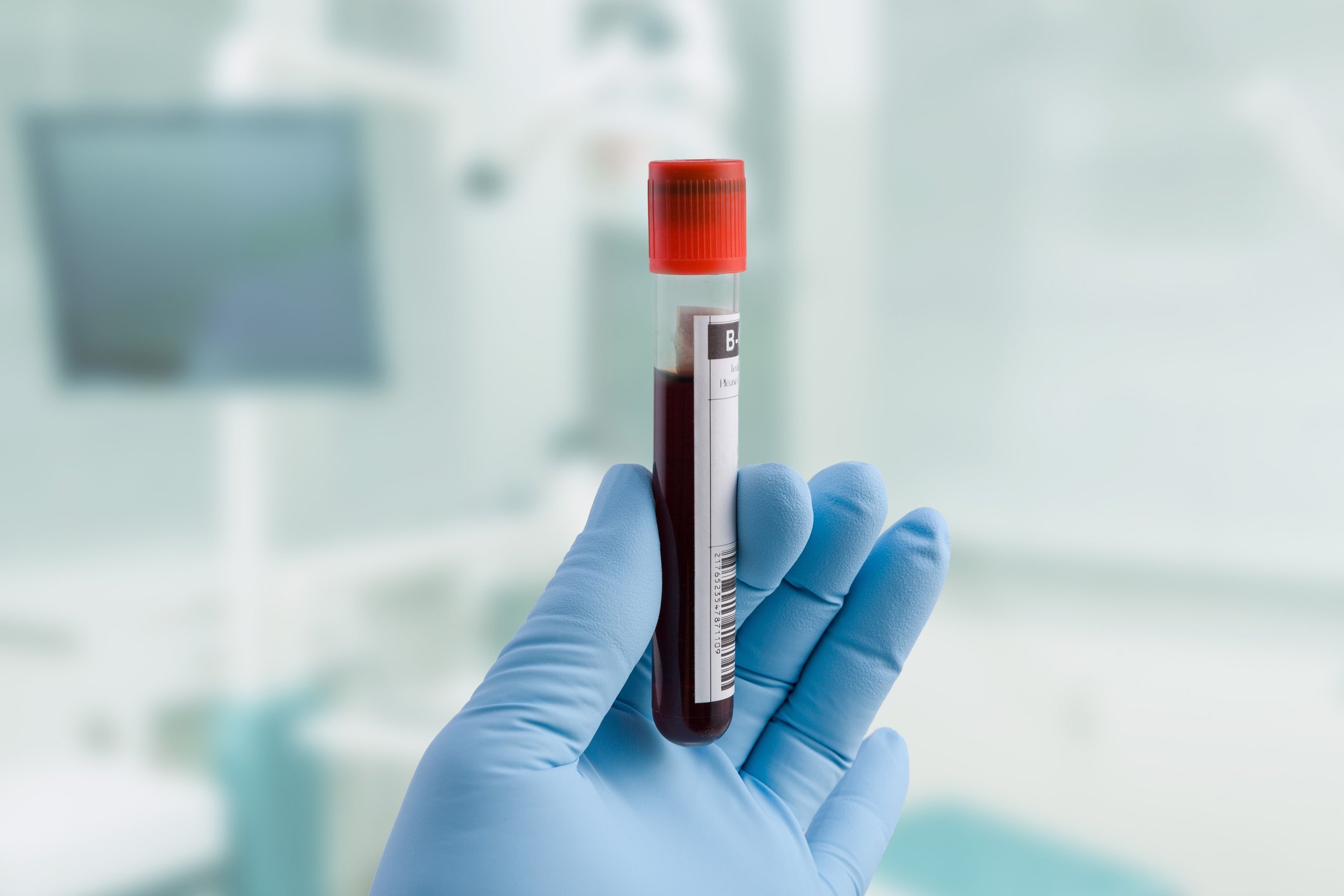Un semplice prelievo permetterà di accertare la malattia molto in anticipo rispetto a oggi (anche di 15 anni). Un passo avanti notevole perché la diagnosi precoce permetterà interventi e terapie prima che si manifestino i sintomi. L’aspettativa è quella di rallentare in modo rilevante il declino cognitivo.
E’ difficile sottostimare la notizia che un nuovo test basato su un esame del sangue potrebbe diagnosticare il morbo di Alzheimer senza ricorrere a esami complessi come la puntura lombare. Con un semplice prelievo, esami radiologici e test psicometrici sarà più semplice, rapido ed economico giungere alla diagnosi. Potremo accorgerci per tempo di una malattia che è una priorità mondiale. Secondo l’Associazione italiana malattia di alzheimer, ogni anno vengono diagnosticati 150 mila nuovi casi. Il numero totale di malati si aggira sui 600 mila, con tre milioni di persone coinvolte nell’assistenza. L’efficacia del nuovo test, non ancora approvato dall’Agenzia de farmaco, è stata dimostrata con uno studio dell’Università di Göteborg, apparso su Jama Neurology, su 800 persone. Il test misura i livelli di una proteina chiamata P-tau217 che inizia ad attaccare i neuroni almeno 15 anni prima dell’insorgenza di sintomi quali perdita di memoria e declino cognitivo. Una volta che il farmaco avrà il via libera, sarà possibile effettuare un test per questa proteina.
«È un esame adatto a tutti coloro che mostrano i primi segni dell’Alzheimer, come perdita di memoria a breve termine. È accurato solo nel rivelare in modo più agevole la presenza di placche di beta-amiloide nel cervello, semplificando l’iter diagnostico in pazienti già affetti da decadimento cognitivo» chiarisce Marzia Baldereschi, dell’Istituto di neuroscienze del Cnr-In. «Si ipotizza, ma non è una certezza, che quando il test verrà effettuato in assenza di sintomi, per esempio con 15 anni di anticipo, un progressivo aumento della P-tau217 potrebbe predire l’insorgenza dell’Alzheimer. Ecco perché c’è chi ha parlato di farne uno strumento di screening per gli ultracinquantenni. Ma è una tesi da dimostrare. D’altra parte, con una diagnosi precoce si potranno programmare gli aiuti al paziente».
In una persona senza sintomi che abbia una predisposizione genetica familiare, questo esame avrebbe senso? «Non si vede ancora il beneficio di un test del genere» risponde Baldereschi. «Bisogna tenere presente che un farmaco capace di sconfiggere la malattia non esiste, anche se ne stanno per arrivare alcuni che ne rallentano la progressione. Ciò che rende davvero il test importante è il fatto che semplificherà molto le attuali procedure di diagnosi». Oggi fatte per esclusione più che con un analisi specifiche, usando tecniche avanzate di imaging del cervello e questionari per valutare il decadimento mentale. Uno degli autori dello studio, Daniel Alcolea del Sant Pau Research Institute (Spagna) conferma: «Serviranno ulteriori conferme, come esami radiologici e psicometrici, ma gli accertamenti richiesti saranno meno invasivi e in numero inferiore rispetto a oggi. Il vantaggio del nuovo test? Una rilevazione ai primi sintomi permetterà di programmare in anticipo l’accesso a “trial” clinici, la gestione del paziente, ed eventualmente l’accesso a terapie che rallentano la malattia».
L’accuratezza della predizione è intorno al 90 per cento (mentre oggi un terzo dei casi sfugge alle diagnosi, specialmente nelle prime fasi). L’azienda ALZpath che ha sviluppato il test stima che il suo costo sarà tra 200 e 500 dollari. A renderlo importante è anche un’altra circostanza, non di poco conto. Siccome sono allo studio un migliaio di molecole per l’Alzheimer, tanto più efficaci quanto più la diagnosi è precoce, l’aspettativa è che un giorno si possa ridurre la progressione della malattia. Tra i più promettenti, il Lecanemab, dalla giapponese Eisai con la statunitense Biogen, e il Donanemab, dell’americana Eli Lilly. Il primo, approvato lo scorso settembre dalla Fda, negli Usa, è un anticorpo monoclonale, noto come BAN2401 (principio attivo Leqembi), che rallenta del 27 per cento l’avanzare della patologia a livello cognitivo e funzionale.
Anche il secondo farmaco, il Donanemab, noto come N3pG, è un anticorpo che riduce l’eccesso della proteina beta-amiloide, fattore chiave nella malattia. L’ok della Fda potrebbe arrivare nel giro di settimane o mesi. Uno studio di fase III uscito sulla rivista Jama ha mostrato un rallentamento del declino cognitivo e funzionale del 35 per cento rispetto al placebo (che sale al 60 quando la diagnosi è precoce), e una riduzione delle placche amiloidi. «Non è una cifra significativa, ma è già qualcosa» commenta Baldereschi. «Il problema sono i possibili effetti collaterali quali emorragie ed edema cerebrale, a volte risolvibili in circa dieci settimane. I pazienti che prendono già anticoagulanti orali, o hanno un gene APOE4, sia omozigoti sia eterozigoti, non potranno assumerli. Si tratta del 75 per cento di tutti i malati di Alzheimer. Siccome queste molecole non arrestano la malattia, gli interventi non farmacologici avranno sempre un ruolo cruciale. Ma chissà che i nuovi farmaci, opportunamente migliorati, non diano risultati ancora migliori di quelli finora raggiunti.