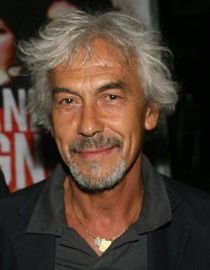Appena apro gli occhi, canto per la libertà – La recensione
Una rock band contro il regime nella Tunisia del 2010, ancora sotto la dittatura. Una voce pericolosa e critica? Meglio farla “educare” dalla polizia
Se sei un tipo “scomodo” sparisci in un baleno. Puff. E ti ritrovi tra le grinfie di poliziotti maneschi, capaci di tutto pur di farti cantare in una stanza di pareti graffiate e maioliche sporche, dove nessuno può sentirti piangere o urlare. E dove la parola cantare, come vedremo più avanti, può avere più valenze o assumere addirittura toni beffardi.
Non pensate alle cronache di oggi, agli omicidi senza colpevoli o ai governi reticenti. Si parla della Tunisia del 2010, prima della rivoluzione e della Primavera Araba, ancora col dittatore Ben Alì e il suo partito in sella , pugno di ferro e spari al primo alito di vento contrario. È il poco accogliente habitat politico-sociale scelto dalla regista Leyla Bouzid (figlia di un numero uno del cinema tunisino come Nouri Bouzid) per raccontare, alla sua opera prima, tutto il proibito di un paese all’epoca di quella tirannia. Il titolo del film, opera prima della cineasta, è Appena apro gli occhi (in sala dal 28 aprile) e coincide col titolo di una canzone che fa da leimotiv alla storia ed è un po’ il cavallo di battaglia della giovane protagonista Farah (Baya Medhaffer): la quale, appunto, fa la cantante in un gruppo rock-folk di protesta che poco a poco comincia a farsi largo nella Tunisi di Ben Alì. Con buona musica e parole taglienti.
Quelle parole taglienti
Il regime, come si dice, sopporta certe cose come il fumo agli occhi. Specie se, al proposito, canzoni come Appena apro gli occhi parlano di gente piena di problemi, privata del lavoro e del cibo, di uomini “che si ritirano in esilio e attraversano l’immensità dell’oceano in pellegrinaggio verso la morte”. E ancora: “A causa dei problemi del loro Paese le persone perdono il senno alla ricerca di nuovi problemi, diversi da quelli che già conoscono. Vedo persone che si stanno spegnendo. Impregnate del loro sudore, le loro lacrime sono salate, il loro sangue è stato rubato e i loro sogni sono sbiaditi…”.
Una madre "contro"
Insomma, sembra niente. Ma “quella” Tunisi non gradisce. Farah e i suoi compagni di band (di uno di loro, Borhène, l’attore Montassar Ayari, s’innamora scoprendo anche il sesso) lo sanno ma continuano a suonare senza ostacoli apparenti. L’unico intoppo, a dire il vero, sembra quello che Farah trova in sua madre Hayet (Ghalia Benali) - meno in suo padre Mohamoud (Lassaad Jamoussi) che lavora fuori città e torna di rado – decisa a far studiare sua figlia all’università iscrivendola alla facoltà di medicina; non negandosi peraltro di controllarla da vicino, insospettita dalle tante voci che girano sul suo conto. Tra “cattive compagnie” e spirito disfattista.
Il canto soffocato
Inevitabile, tra Farah e sua madre, lo scontro doloroso che le porta alla separazione. Ancora più dolorosa, perché irreparabile, è tuttavia la repressione che i servizi speciali operano sulla band, considerando pericolosi i suoi i testi di opposizione e di protesta: prima incominciano a chiudere i locali dove il gruppo deve suonare, poi mettono le mani su Farah. Che repentinamente scompare, svanita nel nulla. In realtà acciuffata dagli agenti, strapazzata a sufficienza e infine restituita ai genitori, non tumefatta ma, forse peggio, privata d’ogni fierezza e voglia di ritrovare il microfono.
Un’oggettività partecipata
Sarà proprio sua madre, nell’epilogo, a farle tornare la voglia di vivere. Quasi un “finale aperto”, a lasciar presagire l’esito meno fosco che la Storia ha riservato alla Tunisia negli ultimi anni. Leyla Bouzid, che vive a Parigi, riesce a dare un tocco molto oggettivo al suo racconto, pure in una forma di sensibile e tangibile partecipazione ai casi della giovane cantante. Il rock della sua band, grondante sonorità tradizionali d’oriente ma non lontano dall’indie occidentale, è per natura rivoltoso anche se sono le parole affilate a tranciare le (cattive) coscienze degli interlocutori più permalosi, inquisitori e forcaioli.
Tensione drammatica
Chissà se la regista, quando ha escogitato questa storia, non abbia pensato al percorso dei Mashrou' Leila, il gruppo libanese diventato emblema musicale della Primavera Araba. Fatto sta che proprio la musica, oltre gli attori (armoniosa e benigna Ghalia Benali nella parte della madre, di enorme vivacità la Farah di Baya Medhaffer) è mattatrice del film, occupandone larga parte, determinandone ragioni e sviluppi. “Tutti abbiamo dei problemi – dice in una scena uno dei musicisti – perché suoniamo, altrimenti?”. Frase quasi programmatica, all’interno di una tematica basica, elementare, poggiata (e raccontata con lodevole tensione drammatica) su una semplice richiesta di libertà: non solo di suonare e cantare, ma anche e soprattutto di vivere.