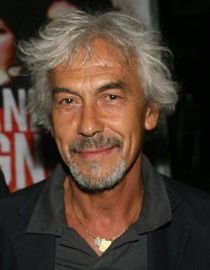"A Ciambra" all’Oscar 2018: perché non ci ha convinto
La commissione ha scelto il rigore sociale e la realtà rom, giocando anche la carta Scorsese. Ma avremmo preferito altri film
A Ciambra, il film candidato dall'Italia per l'Oscar al miglior film straniero, è fuori dalla corsa all'Academy Award. Si è visto superato dal cileno Una donna fantastica, dall'ungherse On body and soul, dall'israeliano premiato a VeneziaFoxtrot, dal libanese L'insulto sempre passato (e premiato) all'ultima Mostra del cinema veneziana, dal russo Loveless, dal senegalese Felicité, dal sudafricano The wound e dallo svedese vincitore di Cannes The square. Le nomination finali saranno annunciate il 23 gennaio 2018, gli Oscar consegnati il 4 marzo.
Noi l'avevamo detto: A Ciambra non ci sembrava la scelta migliore, come film alfiere del nostro cinema. Ecco perché.
-------------
(Articolo del 27 settembre 2017, aggiornato il 15 dicembre 2017)
A Ciambra, dunque. Un po’ sulla linea di un cinema italiano che oggi, per proporsi sui palcoscenici internazionali, sembra scegliere - non si sa bene se inconsciamente o in modo consapevole - quei film meno esposti sul mercato, annidati nel rifugio dialettale in versione sottotitolata, quasi frutto di una polverizzazione produttiva di matrice regionale benedetta dalle film commission.
Questa la candidatura italiana agli Oscar 2018, che non vuol dire, come si sa, partecipazione diretta: sarà così valida da convincere l’Academy a inserire quest’opera seconda di Jonas Carpignano – autore italoamericano 33enne salito repentinamente alla ribalta nel 2015 con Mediterranea – nel novero dei film candidati alla statuetta tra quelli girati in lingua non inglese?
Lo si vedrà, naturalmente con il migliore augurio. Ma anche con le incertezze di una cinematografia che negli ultimi dieci anni ha vissuto un solo tripudio (La grande bellezza di Paolo Sorrentino) e un solo ingresso nella short-list di nove candidati (La sconosciuta di Giuseppe Tornatore poi escluso dalla cinquina), salvo il dirottamento di Fuocoammare di Gianfranco Rosi nella più congrua sezione documentaria.
La trama
Verso l’Oscar 2018, così, con una avance molto autorale che parla col linguaggio di una “cronaca come dal vero” di una piccola comunità rom insediata nei sobborghi di Gioia Tauro: dove l’occupazione preferita degli adulti inclina verso il furto d’auto senza tralasciare altre varianti di sottrazione, inclusa quella dell’energia elettrica pubblica o privata; e dove un giovane di nome Pio, più o meno quattordicenne, aspira tra molte contraddizioni a fare un giorno il lavoro dei “grandi”.
Tutto questo in un habitat sociale ovviamente ostico e di tortuoso accesso fatto di neri immigrati e bianchi malavitosi locali, di quotidianità e tensioni, illegalità e sordidezze, simboliche transizioni temporali sulla cultura rom e sulla maturazione del giovanissimo protagonista.
Cosa ci è piaciuto
Stile asciutto, macchina in spalla con forte vocazione dinamica all’immagine “sporca”, naturalismo accuratamente dribblato a metà strada fra echi di cinema-verità e di neorealismo, curiose e temporanee tentazioni felliniane.
All’interno di un tessuto umano che, avendolo praticato, vissuto e condiviso a lungo fin quasi a farne parte, il regista conosce benissimo. Tanto da riuscire nel piccolo miracolo di utilizzare nel film i personaggi reali, Pio, Iolanda, Damiano Amato e tutti gli altri della famiglia rom (meno il “nonno”, scomparso davvero tempo addietro dunque reinterpretato, ma con le sue stesse parole) lasciandoli recitare come nella vita, nel modo il più abituale possibile.
Logicamente non sarà stata estranea alla scelta, da un punto di vista “strategico”, la presenza prestigiosa di Martin Scorsese nelle vesti di produttore esecutivo. Un nome che, come si dice, può fare un certo effetto in ottica americana, sempre, però, guardando alle relazioni reali del maestro con l’establishment dell’Oscar.
Cosa non ci è piaciuto
Nonostante le sue virtù socio-culturali e l’innegabile acume nei modi di ripresa e di esplorazione ambientale, il film è imperfetto. E, come scrivemmo a suo tempo nella recensione all’uscita in sala lo scorso fine agosto, il limite, se c’è, resta nella persistenza di alcune inquadrature e nella ripetitività dell’azione che sviluppano la vicenda oltre i margini narrativi più congeniali agli stessi modi con i quali questa viene rappresentata.
Nel senso che alla sobrietà, alla stringatezza e all’essenzialità dell’ispirazione corrisponde piuttosto una curiosa tendenza al ristagno o, ancora, ad una prolissità a volte enfatica riflessa sulle due ore di proiezione. E, al di là delle sempre opinabili riserve critiche, lascia affiorare dubbi la tendenza a presentare il cinema italiano in climi di marginalità talmente accentuati e “solidali” (in questo caso anche con la tendenza a delinquere per necessità o cultura) da ammiccare, anche nei modi, a certe derivazioni di quello terzomondista.
Da una parte con l’auspicio di seguirne le fortune da festival internazionale, dall’altra con l’assillo del “politicamente corretto” da esibire ad ogni costo. Sia chiaro, senza con questo discutere il film in sé ma il disegno che ne ha sorvegliato la selezione.
Perché ci sarebbe piaciuta un’opzione diversa
Sarà, ma personalmente avremmo preferito dell’altro. Non certo da scovare tra i blockbuster – dei quali, peraltro, il cinema italiano è avarissimo – piuttosto tra film della stessa fascia di fruizione di A Ciambra, magari meno dipendenti dal “sociale ad ogni costo” eppure egualmente ricognitivi e investigativi, custoditi e in qualche modo protetti nella loro identità idiomatica, a volte folclorica, certamente più legata al concetto di storia e morbidamente poggiata sui sentimenti.
Parliamo diSicilian Ghost Storydi Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, uscito a maggio, dove la crudezza della mafia e la leggerezza degli affetti cullano lo spettatore nell’incertezza fra la tragedia reale e il trionfo ideale dell’amore (impossibile?) fra due ragazzi: nella Sicilia “magica” di un racconto costantemente sospeso fra le due sfere, appunto quella fisica e quella fantàsmica.
Molto abbiamo amato questo intreccio visionario e dialettico. Così come, su altri versanti di stile narrativo, ci conquistò - anche questo a maggio, mese evidentemente giusto per certe cose - l’opera prima di Roberto De Paolis, Cuori puri, sorprendente, spiazzante, incantevole e perfino commovente nella sua semplicità di relazione amorosa in ambiente romano fra due giovani che paiono agli antipodi.
Lei a vivere il mito della verginità in habitat parrocchiale perseguitata da un madre ossessivamente pia; lui generato da una periferia romana della quale, pur assorbendo una certa inclinazione coatta, ripudia la deriva malandrina in nome di un’innata, generosa mansuetudine pasoliniana.
Quando s’incontrano, accendendo un amore che sembrerebbe estraneo alle loro nature e culture antitetiche, paiono trovare una via soltanto terrena, ma vera e meravigliosa, alla purezza. Pier Paolo Pasolini. Ma anche Robert Bresson. Lontani e al tempo stesso vicini.