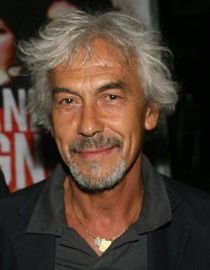Dark Night, notte di sangue in Colorado – La recensione
Da Tim Sutton, filmmaker indipendente, l’anatomia della strage di Aurora nel 2012: la carneficina in sala alla prima del “Cavaliere Oscuro”
Tracce di Beat Generation e schegge di Underground. Non è roba di contenuti ma di stile e di messaggi da un altro mondo. Perché quello che il talento indipendente di un filmmaker come Tim Sutton raccoglie in Dark Night (in sala dal 1° marzo, durata 85’) insegue fiotti culturali lontani, di derivazioni letterarie (Ginsberg, Kerouac, Ferlinghetti, Orlovsky) e cinematografiche (il New American Cinema, dunque Mekas, Clarke, Frank, Markopoulos e prima di loro Brakhage e Anger). E, insieme, le intuizioni di un esegeta o, se si preferisce, un iniziato come Gus Van Sant. Tutto questo per raccontare i prodromi della Strage di Aurora, Colorado, nel 2012, quando il giovane ex dottorando in neuroscienze James Holmes fece dodici morti e una sessantina di feriti a colpi di fucile in un cinema durante la prima del Cavaliere Oscuro.
Vittime e carnefice anonimi protagonisti della tragedia
Nell’avvicinarsi lento e quasi distratto, ma ineludibile, dell’ora fatale si spandono le schegge di un racconto polverizzato in minime tracce vitali di alcuni fra i personaggi (giovani attori per lo più sconosciuti), vittime e carnefice, protagonisti della notte di sangue: tra ragazzi cultori dello skateboard a una donna schiava dell’attività ginnica, a due commesse d’un supermarket a un giovane condannato ai domiciliari, a un reduce di guerra, naturalmente all’assassino, cui l’identità viene affibbiata solo a giochi quasi fatti, quando prende le “misure” del luogo da colpire e quando entra in azione nel finale sospeso, congelato, evanescente e terribilmente aereo.
La trappola dei videogames e della morte virtuale
Nel titolo Sutton incrocia il calembour, elidendo una “k” e riducendo a dark night il titolo originale del Cavaliere Oscuro che è, appunto, Dark Knight, là dove anche la parola dark assume diverso significato, ben più spaventoso di quello legato al Batman di Christopher Nolan: in un intreccio inestricabile tra la realtà e la sua revisione artistica.
Perché di film d’arte si parla, nella sua rappresentazione sincopata di scansione jazzistica, nell’estrema frammentazione ellittica di un montaggio dalle molte linee parallele, nel côté sociologico legato alla trappola dei videogames e alla loro estetica della morte virtuale (fa strano, all’assassino, che i veri morti ammazzati non si rialzino come accade nei videogiochi) oppure alla spaventosa cultura americana dell’armamento diffuso.
Angoscia e violenza senza scene violente
La cifra è ossessivo-distorsiva e strangolante. Il racconto trabocca d’angoscia e di violenza, senza che una sola scena sia violenta, che il racconto fradicio di morte mostri una sola traccia di aggressività nella rappresentazione d’una vita civile che scorre placida mentre l’aspirante killer ragiona sul da farsi. È l’anatomia di una strage. E pure l’anatomia di un cinema che quasi azzera i dialoghi e abbandona la narrazione tradizionale lasciando che una storia si sviluppi e progredisca attraverso la non-azione.
Maica Armata, la poetessa musicale canadese
A proposito di Van Sant, se si pensa a Elephant non si fa peccato. Tenendo sempre d’occhio, si capisce, le due precedenti perle di Sutton Memphis e Pavillon rispetto alle quali la presente, oltre che diversa, è certo la più brillante. Difficile non innamorarsene. E difficile staccarsi dalla logica strutturale di un film cui partecipano con pari valore e magnetismo le immagini e i suoni: da una parte la fotografia rivelatrice e “semantica” di Hélène Louvart; dall’altra le canzoni e la voce liquida di Maica Armata, vera poetessa musicale canadese che qua, impastando la sua voce con l’accordo acustico, incanta e seduce oltre ogni dire.