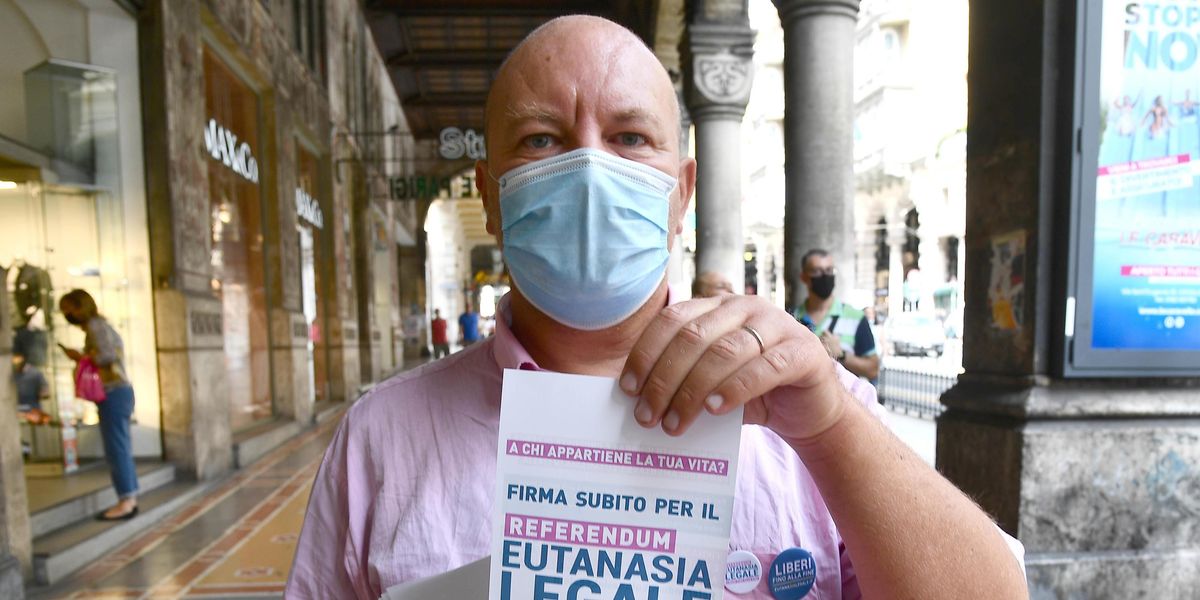L'illusione dell'autodeterminazione
Il via libera all'eutanasia per alcuni è simbolo di libertà. In realtà è l'esatto opposto
Ole Hartling, medico, già membro e direttore del Consiglio danese per l'etica (l'omologo del nostro Comitato Nazionale di Bioetica) ha pubblicato un interessante articolo sul British Medical Journal, sull'illusione dell'autodeterminazione (Euthanasia and assisted dying: the illusion of autonomy) .
La legalizzazione dell'eutanasia o suicidio assistito, o testamento biologico (alla fine, in sostanza, non ci sono differenze reali: si tratta sempre di morte procurata di un soggetto più o meno consenziente) è considerata dalla propaganda radicale come la massima espressione della libertà, o meglio dell'autodeterminazione.
Hartling è profondamente scettico. Di recente ha pubblicato un libro, Euthanasia and the Ethics of a Doctor's Decisions: An Argument Against Assisted Dying , edito da Bloomsbury, in cui tprecisa che non tiene conto di questioni metafisiche come la sacralità della vita, ma che usa argomentazioni del tutto laiche che mirano a dimostrare che la legalizzazione delle pratiche eutanasiche non garantisce affatto il diritto all'autodeterminazione degli individui.
E così, nell'articolo sul BMJ Hartling espone alcune delle criticità che sorgono quando la "morte assistita" viene legalizzata.
Primo punto.
Tutte le nostre decisioni essenziali vengono prese in relazione ad altre persone, sono influenzate da altre persone e influenzano altre persone: siamo tutti vulnerabili e dipendenti dagli altri (quindi non è vero che la legalizzazione della morte assistita non deve interessare chi della stessa non vuole fruire).
Comunque, dice Hartling, riteniamo che se siamo in grado di controllare le nostre vite, allora sicuramente possiamo anche controllare la nostra morte. La libertà di morire, però, nasce comunque dimezzata: si può scegliere di morire se non si vuole vivere, ma non si può scegliere di vivere se si sta per morire.
Inoltre, chi decide di morire non lo fa nei normali contesti quotidiani. Il desiderio di morire nasce sempre in un contesto di disperazione, data dalla convinzione di essere inutili. In queste circostanze la famosa autodeterminazione ha una base molto fragile e una base ancora più fragile ha qualsiasi processo decisionale. Insomma, la "volontà di morire" si forma in un contesto molto diverso - e molto più fragile - della volontà di sposarsi o di cambiare lavoro.
Secondo punto.
Il "diritto di morire" si trasforma facilmente nel "dovere di morire".
Quanta autonomia, quanta libertà è in grado di esercitare una persona in situazione di fragilità (per età, malattia ecc.) quando il mondo che la circonda ritiene che la sua vita non sia degna di essere vissuta? Il paziente di fatto non è "libero" di scegliere la morte: non può sottrarsi al dover scegliere la morte che appare l'unica via d'uscita alla sua condizione di sofferenza. Hartling la chiama la "prigione della libertà".
Cita in proposito il professore statunitense di etica biomedica, Daniel Sulmasy, che parla di "pressione esterna interiorizzata"; il bioeticista francese Emmanuel Hirsch che afferma che l'autonomia individuale può essere un'illusione; il teologo Nigel Biggar che dice che se un paziente vuole veramente morire, il più delle volte si tratta della interiorizzazione dell'atteggiamento di coloro che lo circondano, o della società nel suo insieme, che non credono più nel valore della sua vita e glielo segnalano in tutti i modi (anzitutto con la legge: non dimentichiamo l'insegnamento socratico del valore pedagogico della norma statuale). Biggar espone un paradosso supremo: «qualcuno viene scacciato dalla terra dei vivi e crede che sia lui, in prima persona, a voler morire».
Terzo punto.
Chi usa il suo presunto diritto all'autodeterminazione per scegliere la morte preclude a se stesso qualsiasi altra scelta o decisione: la morte è la fine di ogni libertà. Chi mi circonda deve rispettare il mio diritto all'autodeterminazione? Il rispetto si deve a una persona (che viene rispettata), ma in questo caso la persona scompare, non c'è nessuno da rispettare. Il filosofo danese Johannes Sløk, sostenitore della legalizzazione della morte assistita, ha affermato - onestamente - che la morte è uguale al nulla e non si può scegliere tra la vita e il niente. Quindi ammette che se si rinuncia alla vita non si sceglie altro. Non c'è scelta. Ergo, non c'è libertà (di scelta).
Quarto punto.
Gli ordinamenti moderni che sanciscono l'autonomia dei pazienti riconoscono il diritto di rifiutare qualsiasi trattamento, ma non il diritto a ricevere qualsiasi prestazione che il paziente possa desiderare. I medici non sono mai obbligati a fornire le cure richieste dall'assistito. Anch'essi godono di una loro autonomia professionale e quindi del diritto di dire di no.
In caso di morte assistita, invece, in capo al medico sorgerebbe il dovere di uccidere (direttamente o indirettamente non cambia la sostanza) il che è oltretutto contrario al principio fondante la professione medica "primum: non nocere".
Quinto punto.
A un medico viene dato il potere di valutare se la vita di quel paziente vale la pena di essere vissuta. Quindi, alla fine, deciderà il medico (o l'equipe medica) della sua vita o della sua morte e l'autodeterminazione del paziente risulterà affievolita. Vale a dire: la giustificazione della morte assistita nasce dal presupposto che certe vite non sono degne di essere vissute, piuttosto che dalla presenza di una richiesta del malato. Il rispetto del diritto all'autodeterminazione diventa relativo.
Sesto punto.
Un paziente sopraffatto dalla sofferenza può avere più bisogno di compassione, cure e amore che di un'offerta gentile di porre fine alla sua vita.
E a questa ultima considerazione di Hartling fa da corollario l'esperienza dei Paesi dove la "morte assistita" è stata legalizzata: in Canada le persone uccise perché sofferenti sono state 1.018 nel 2016 e 21.589 nel 2020 (dati ufficiali del Governo).
Se si elimina il sofferente, anziché adoperarsi a lenire la sofferenza, che interesse avranno i medici e gli operatori sanitari a specializzarsi nella palliazione e nella riabilitazione? E perché adoperarsi nella ricerca e nella cura di malattie invalidanti, dalla Sla, alla demenza, al cancro…?
In Italia, oggi, solo il 30% dei malati oncologici ha accesso alle cure palliative. E nel settore pediatrico è anche peggio. Potrà migliorare la situazione dopo l'introduzione dell'eutanasia (o suicidio assistito, che dir si voglia)? Ovvio che no.
Si abbia il coraggio di dire, senza ipocrisia, che gli anziani, i disabili, i malati e - in genere - gli "infelici" danno fastidio: eliminarli serve a potersene andare in vacanza spensieratamente, a risanare i conti pubblici e a risolvere il problema dell'invecchiamento della popolazione. Si illudano pure che stanno compiendo un gesto di autodeterminazione.
info: provitaefamiglia.it