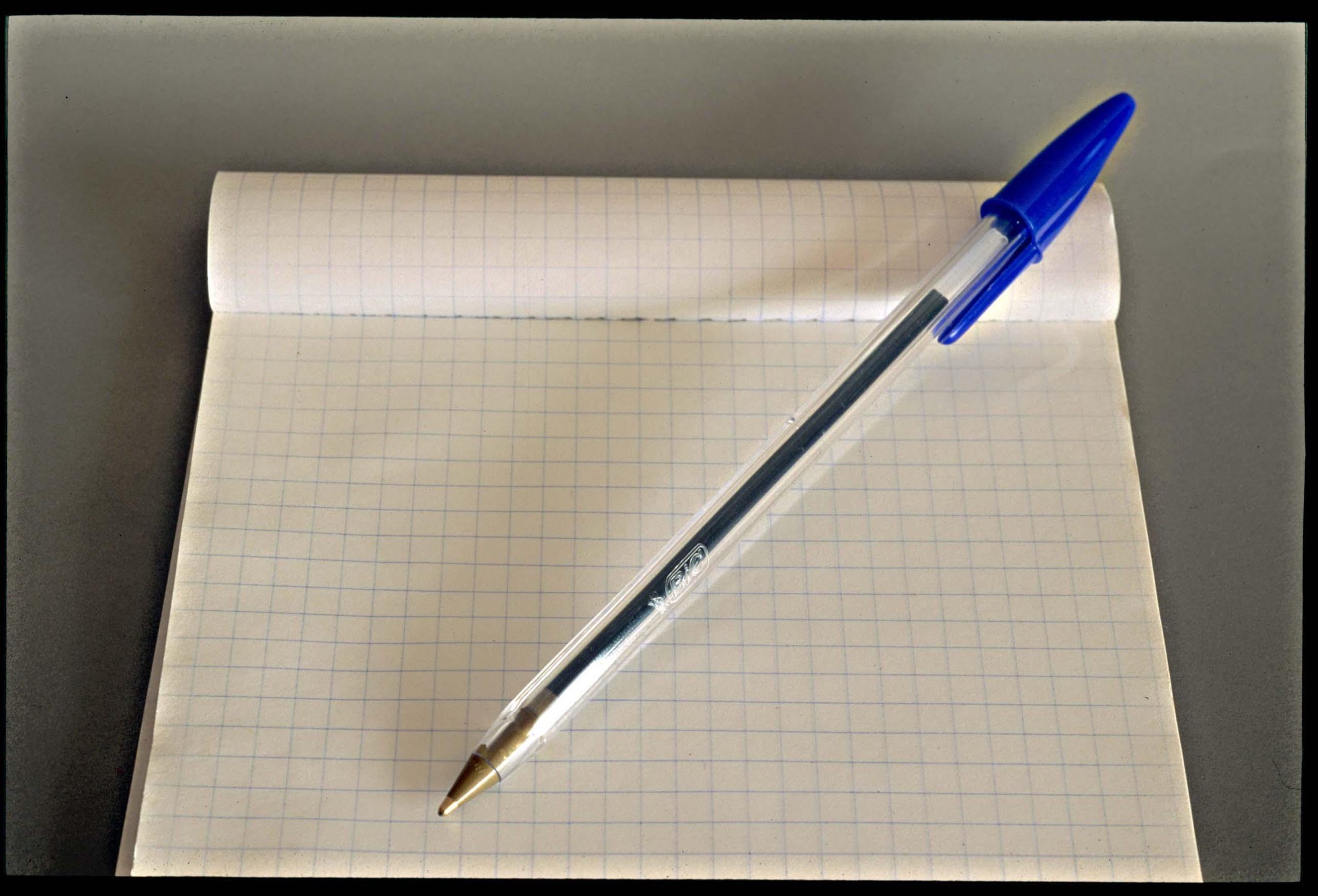Diventò oggetto di massa nel 1951, prima in Francia, poi nel resto del mondo. L’invenzione dell’ungherese Ladislao Biro resta un emblema di resistenza analogica in un mondo sempre più digitale. La tecnologia, consapevole di non riuscire a pensionare la penna, si è messa a imitarla. E ora ne esistono tante versioni evolute per i gadget più usati.
Un incubo agitava le notti degli iscritti a un grande ateneo romano. Aveva per protagonista un noto sociologo che, all’inizio degli esami, poneva domande molto spiazzanti. Una risposta sbagliata sarebbe coincisa con un’immediata bocciatura. Tra i quesiti ricorrenti, uno riguardava la biro: «Che cos’è questa» chiedeva mite il professore agitando una stanghetta dal coperchio blu. «Una penna» rispondeva spedito lo studente, condannandosi alla squalifica, al ritorno obbligatorio all’appello successivo. «È un tratto culturale» sentenziava imperturbabile il sociologo, indicando platealmente la porta.
Spietatezza e torture universitarie a parte, l’aneddoto contiene una verità: la penna non è un solo un oggetto d’uso comune, ma uno specchio del tempo che l’adotta. Oggi, anzi, qualcosa di più: uno straordinario caso di permanenza, di resistenza analogica in un’epoca di trionfo dell’immateriale. Abbiamo pensionato fax e videoregistratori, condannato alla polvere musicassette e cd-rom, veneriamo pc e telefonini, ma teniamo ancora con noi l’insostituibile invenzione che porta il cognome del giornalista ungherese Ladislao Biro. Un mestiere coerente con il suo stratagemma: usare per gli appunti a mano libera l’inchiostro dei quotidiani. Si asciugava molto rapidamente, era perfetto per ancorare pensieri sfuggenti alla carta.
Lo strumento, però, appariva rudimentale e costoso, finché non ci mise le mani e l’ingegno il barone Marcel Bich. Nato a Torino nel 1914, comprò il brevetto di Biro assieme al socio Edouard Buffard e lo perfezionò: trovò la ricetta segreta per l’inchiostro, prese dall’alta orologeria svizzera gli strumenti per creare il meccanismo grafologico perfetto. Così nasceva la Bic cristal, economica e dal tratto scorrevole. Un immediato successo: ne furono venduti 10 mila pezzi al giorno nei primi 12 mesi della commercializzazione, esattamente 70 anni fa. Ancora oggi, ogni 24 ore, ne vengono acquistati vari milioni in tutto il mondo. È all’altezza di qualsiasi tasca e alfabeto, ognuna compila righe di testi che, se messi in fila, raggiungerebbero i tre chilometri di lunghezza.
È un’opera d’arte, senza esagerare: fa parte delle collezioni permanenti del MoMA di New York e del Centre Pompidou di Parigi.
Sa adeguarsi al presente, con la Cristal Re’New: stesse performance dell’originale e accortezze sostenibili. È ricaricabile, ha il fusto in alluminio mentre il cappuccio deriva per il 96% da plastica riciclata. Mutano gli ingredienti, non la sostanza: con i suoi 70 anni, la Bic è una nonna nel pieno delle forze che porta dentro di sé il solido tratto dell’esperienza. Resta una ribelle, per i colpi di cerbottana che ancora lascia assestare tra i banchi delle scuole: un’evasione più reale di qualunque videogioco virtuale.
Arriva a smentire addirittura il New York Times, che nel 2014 ne preconizzava il definitivo tramonto in un articolo-funerale: avremmo fatto tutto col dito, il touch l’avrebbe toccata fatalmente. Invece è ancora qui, nemmeno troppo per inerzia: la società di ricerca Euromonitor international prevede vendite in crescita in Italia per il 2021 dopo la frenata del 2020. La pandemia stessa ne ha sancito l’essenzialità, tra autocertificazioni e scartoffie varie da compilare in movimento.
La penna è un feticcio, una coccola per la memoria: la rubiamo negli hotel, rimane il souvenir prediletto dopo la visita a un museo.
Non ci ricorda solo dove siamo stati, racconta chi siamo: «Prendere in mano una penna e metterla a contatto con un foglio rivela tante di quelle cose di una persona che probabilmente è impossibile elencarle tutte» scrive Luca Barcellona in un libro da poco uscito per Utet, Anima & inchiostro. Scrivere a mano come pratica per migliorare se stessi.
Barcellona è tra gli studiosi ed esperti di calligrafia più quotati al mondo. E nel suo saggio invita a tenere vivo un patrimonio della propria identità: «Quello che è certo è che la nostra scrittura sarà sempre unica. Alcune scritture potranno risultare simili, per affinità nell’approccio, o per emulazione, come spesso mi capitava di notare a scuola guardando gli appunti di due vicini di banco. Ma nessuno potrà mai replicare esattamente il nostro modo di scrivere: una volta apprese le forme delle lettere e la loro sequenza la scrittura diventa un processo automatico, e il gesto grafico diventa anche un gesto espressivo».
La penna resiste in quanto equilibrio di persistenza e metamorfosi, deferenza alla forma originale e sua naturale evoluzione. Non sarà mai un reperto archeologico perché, nel frattempo, è diventata un oggetto tecnologico, con tipicità e aggiustamenti pensati per gli schermi di cellulari e computer: «È uno strumento versatile dotato di funzioni che permettono agli utenti di esprimere se stessi come mai prima d’ora, che si tratti di prendere appunti durante una conference call, modificare foto o video o disegnare schizzi per il loro progetto creativo» riassume Paolo Bagnoli, responsabile marketing della divisione telefonia di Samsung Electronics Italia. Non mancano i benefici concreti: «È un ottimo alleato anche per firmare comodamente e con velocità documenti senza necessariamente doverli stampare e successivamente scansionare per l’invio». Tra esasperazione della praticità e celebrazione della longevità, la biro è l’opposto della nostalgia: è un tratto culturale all’altezza di tante culture. Anche il più esigente dei sociologi promuoverebbe la definizione.