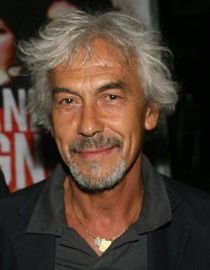Sembra mio figlio, un dolce viaggio verso la madre – La recensione
Costanza Quatriglio dirige con grande sensibilità un film intimista ispirato a una storia vera. Due fratelli simbolo del popolo Hazara e del suo sterminio
Succede di rado che il titolo di un film faccia rima col cognome del suo regista. Ancora più raro che a questa congiuntura si accosti anche la buona qualità del film. Come nel caso di Sembra mio figlio (in sala dal 20 settembre, durata 103’) di Costanza Quatriglio. Naturalmente non ci si perde dietro la facezia della rima, che pure affiora d’impulso, ma si guarda a un film maledettamente serio, che la regista – giusto 15 anni fa il suo esordio alla Quinzaine di Cannes con L’isola, poi altri passaggi di valore come Terramatta e Con il fiato sospeso – lascia galleggiare tra documento e finzione nel tracciato di una storia fatta comunque di notizie vere, raccontata con modo realistico senza far venire meno l’intensità dell’emozione e le tensioni narrative.
Del resto basta guardare alla sostanza storica, politica e sociale che gremisce il racconto per coglierne, da spettatore, il rilievo drammatico. Perché il protagonista Ismail (Basir Ahang), rifugiatosi da anni in Italia col fratello maggiore Hassan (Dawood Yousefi), è il simbolico rappresentante di un popolo tra i più perseguitati della terra, gli Hazara, vittime di genocidio, crimini di guerra e contro l’umanità.
Quel genocidio e quella diaspora poco conosciuti
Li racconta, alla fine del film, una didascalia lunga ma necessaria a spiegare quella tragedia non molto nota ai più: “A causa dei tratti somatici mongoli si dice che discendano dall’armata di Gengis Khan che invase l’Afghanistan nel tredicesimo secolo. Alcuni storici sostengono che gli Hazara siano il popolo autoctono dell’Afghanistan. Originariamente buddisti, attualmente vinono nelle zone centrali del Paese dove le due enormi stature di Buddha, simbolo della loro storia e cultura, sono state distrutte dai talebani nel 2001. Durante il primo tentativo di genocidio del 1890 il 62% della popolazione è stato massacrato. Da allora è in corso la diaspora in tutto il mondo”.
Russi e talebani come una tenaglia sterminatrice. Magari anche qualcun altro a colpire, come i pashtun alla fine dell’Ottocento. Fatto sta che a questa gente, ridotta a meno del dieci per cento rispetto alla consistenza originaria, non resta che la fuga, appunto come quella dei due fratelli, che dimorano nell’estremo nordest d’Italia al confine con la Slovenia lavorando nella maniera più umile e onesta del mondo.
Un devastante incontro ravvicinato con i talebani
Ismail fa anche il mediatore culturale volontario coi profughi suoi connazionali, Hassan si destreggia in riparazioni sartoriali, convivono con dinamiche, si può dire, insolite perché è il minore Ismail – che ha un dolce incipiente innamoramento per una ragazza che ha il volto dell’attrice croata Tihana Lazovich - a doversi occupare amorevolmente del fratello più grande, menomato fisicamente e psicologicamente da un incontro ravvicinato con i talebani all’epoca della loro fase migratoria.
Le lunghe telefonate mute e strazianti
Inoltre sono tristi. Perché non riescono più a comunicare con la loro madre che li spinse a fuggire ancora bambini, che non vedono dunque da una vita e che, per il fatto di essersi appena risposata, ha smesso di “conoscerli” temendo che il nuovo marito, sapendo dei due figli, possa avere reazioni brutali. Si sa come va, con certe culture. Ma loro non si arrendono, malgrado certe strazianti telefonate mute dove Ismail cerca invano di far parlare sua madre: e decidono di partire a cercarla, per riabbracciarla di nuovo, intraprendendo il viaggio inverso rispetto a quello che fecero tanti anni prima. Con gli stessi rischi, però e la stessa crudele ostilità dei territori lacerati dalle guerre.
Una rappresentazione asciutta, sensibile e mai retorica
Il film, girato in modo inappuntabile anche nelle tecniche di ripresa (la fotografia è di Stefano Falivene e Sabrina Varani, molti primi e primissimi piani introspettivi) , riposa sulle dominanti del silenzio, delle parole spese al momento giusto, di un filo intimista che ne attraversa tutto il tracciato. Film di polveri fini, di telefonate struggenti, in definitiva anche di peso civile pari all’intrepidezza, anche produttiva, col quale è stato girato.
E brava Quadriglio, naturalmente, a trasferirne senso e sentimenti attraverso una rappresentazione asciutta e sensibile, mai querula, artificiosa o retorica (sua anche la sceneggiatura, scritta con Doriana Leondeff e la collaborazione di Mohammad Jan Azad). Gli attori, comunque, le danno una mano: senza dubbio Ahang (poeta e giornalista nella vita) e Yousefi , i fratelli, nel distanziamento della loro recitazione; e Tihana Lazovic, che nella semplicità, nel volto e nelle espressioni mi ha ricordato curiosamente Solveig Dommartin, una delle attrici-feticcio di Wim Wenders (con lui Il cielo sopra Berlino e Fino alla fine del mondo) scomparsa assai prematuramente undici anni fa.