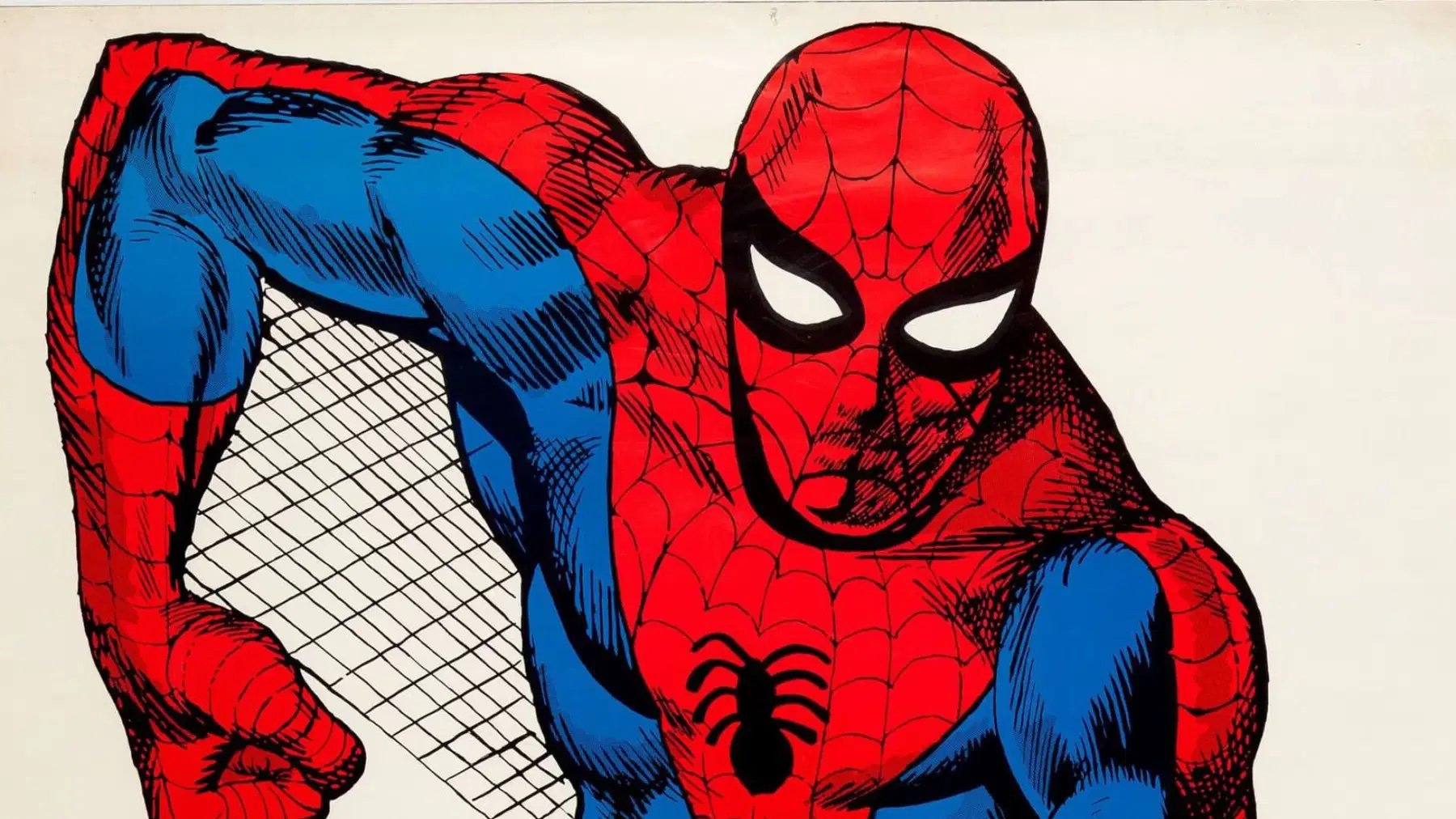I fumetti della Marvel, la celebre casa editrice fondata in America nel 1939, hanno sempre avuto risvolti sociali: i «buoni» e i «cattivi», prima nelle strisce a fumetti poi nei film, raccontano uno spaccato di realtà. E, a Torino, una mostra ne celebrerà le evoluzioni più affascinanti
L’ultima novità dall’universo Marvel è che Robert Downey Jr., l’attore che ha interpretato più volte Tony Stark, alias Iron Man, vestirà l’armatura del Dottor Destino nel film Avengers: Doomsday, in programma per il 2026. E la comunità dei fan è già in subbuglio: infatti chi conosce bene la biografia di Destino, all’anagrafe Victor von Doom, sa che quel personaggio iconico è di origine rom, lontano discendente da una popolazione dell’India, e quindi c’è il rischio di whitewashing, ovvero di cambiare l’etnia originale. Un’occasione per ripassare il Libro di Destino, un tomo di 1.300 pagine che fa luce su una delle figure più riuscite della Marvel. Ma anche l’ennesimo caso in cui i supereroi fanno discutere, passando dal semplice entertainment al dibattito culturale. I fumetti della Marvel, fondata in America nel 1939, hanno sempre avuto un risvolto sociale nelle loro storie: eroi e anti-eroi delle varie serie raccontano uno spaccato della società: l’avvocato cieco che diventa Devil, l’adolescente problematico che impersona l’Uomo ragno, l’aviatore che si trova prigioniero nel corpo di pietra della Cosa, sono tutti personaggi che vivono vite dalle molte sfaccettature, spesso in contraddizione. E anche in virtù di questa ricchezza di risvolti esistenziali la Marvel continua ad avere successo, accompagnando le storie di chi legge quei fumetti, diventando una sorta di nota a margine di milioni di vite. Basti pensare a un boomer che ha iniziato a leggere I Fantastici Quattro e L’Uomo ragno negli anni Sessanta, e che ha vissuto tutta l’evoluzione della casa editrice e delle sue creature. Per quei lettori i personaggi d’invenzione sono diventati in qualche modo amici di famiglia.
Una storia complessa, che sarà raccontata nella mostra Amazing. 80 (e più) anni di supereroi Marvel, in programma dal 6 dicembre 2024 al 9 marzo 2025 a Torino, a Palazzo Falletti di Barolo. Nell’esposizione, curata da Luca Bertuzzi e prodotta da Ares Torino in collaborazione con Wow Spazio Fumetto, si potranno ammirare oltre 80 tavole originali, poster, memorabilia e giocattoli. Come spiega Bertuzzi, «la mostra proporrà tavole scelte dagli anni Sessanta ai giorni nostri, per vedere all’opera i più grandi maestri dei fumetti Marvel, dai fondatori di questo universo narrativo, come Jack Kirby, presente anche con una tavola dei Fantastici Quattro, e John Romita Sr., colui che ha definito l’aspetto definitivo di Spider-Man. Ci saranno poi tavole degli autori che tra gli anni Ottanta e Novanta hanno rivoluzionato l’aspetto visivo dei supereroi, come Todd McFarlane e Jim Lee, fino ad arrivare a grandi artisti italiani come Gabriele Dell’Otto e Simone Bianchi». Come sottolineano i responsabili di Ares Torino, «abbiamo voluto creare una mostra che non solo permettesse di ricostruire la storia di una delle maggiori case editrici dedicate al fumetto, ma che potesse avvicinare il grande pubblico a una narrazione visiva, spesso considerata minore, che a tutti gli effetti è una vera espressione artistica».
Si guarda indietro e si pensa a quante cose sono cambiate, anche nella vita di supereroi e supercriminali. Negli anni d’oro della produzione Marvel, quelli delle storie firmate da Stan Lee e disegnate da Kirby erano protagonisti molti personaggi combattuti tra due diversi modi di essere, supereroi part time afflitti da mille dubbi amletici. Giovani uomini in crisi, come quelli interpretati al cinema da Dustin Hoffman e Al Pacino. Si confrontavano spesso con cattivi risoluti, carichi di risentimento nei confronti di una vita difficile, determinati a prendersi una rivincita personale. Un’innovativa rilettura dell’eroe e dell’antieroe solo con i propri tormenti che ha dato vita a saghe straordinarie calate spesso nel mondo reale, perlopiù a New York, con incursioni nella vecchia Europa, nella nazione immaginaria Latveria del Dottor Destino, o nelle profondità marine, nell’Atlantide di Sub-Mariner. Trame che hanno dato vita a centinaia di personaggi indimenticabili, ciascuno con una propria personalità e un proprio costume da battaglia. I più originali erano i cattivi: Rama-Tut, il faraone del futuro, un «villain» decisamente postmoderno, Mysterio, Electro, il famigerato Goblin, il Teschio rosso, gli Skrull.
Tutto questo riguarda il periodo inarrivabile degli anni Sessanta e Settanta. Successivamente, negli anni Ottanta, vanno in scena le epopee popolate da decine di personaggi, come la serie Guerre Segrete, e poi si propone una dimensione ancora più intima e crepuscolare dei supereroi, con fumetti di culto come il Devil di Frank Miller. È un altro mondo, lontano da quello tutto sommato ottimistico degli scontri persalvare il pianeta di un tempo. E intanto, dopo le prime prove sul grande schermo, prende corpo l’idea del Marvel Cinematic Universe, con film importanti che riscrivono la storia dei fumetti della Marvel. Al contempo cambia lo stile dei disegni e si trasforma il «mood» delle storie. Periodicamente escono capolavori come 1602, una saga che trasporta l’epopea dei supereroi 400 anni indietro, e si reinventano i destini di molti beniamini degli appassionati. Il tempo diventa una variabile dello spazio.
Per orientarsi in questa lunga e passassionante vicenda editoriale, ecco le coordinate del curatore di Amazing. «Per gli anni Sessanta è simbolico Fantastic Four numero 1, perché di tutte le origini dei supereroi Marvel è con loro che inizia l’Universo Marvel che conosciamo oggi» riflette Bertuzzi. «Per i Settanta, indico la morte di Gwen Stacy, l’amore dell’Uomo regano, su Amazing Spider-Man numero 121. È un momento fondamentale per il protagonista e per i fumetti Marvel con lui: segna la perdita dell’innocenza. Un personaggio così importante come Gwen muore tragicamente. Per gli anni Ottanta La saga di Fenice Nera, in Uncanny X-Men, una storia che ha portato i cosiddetti mutanti a un eccezionale successo di vendite che hanno poi mantenuto per moltissimi anni. E ancora: per i Novanta, Marvels: una storia del 1994, che in un decennio ricordato anche per le esagerazioni narrative e grafiche ritorna alle origini della casa editrice attraverso l’inedito punto di vista dell’uomo della strada, con un disegno in stile pittorico che ha fatto scuola. Infine per i Duemila scelgo Ultimate Spider-Man. È l’avvio di un ennesimo ripensamento dei supereroi Marvel, in un nuovo universo narrativo, per poter avvicinare tanti nuovi lettori».
In una così lunga e complessa evoluzione, chi aveva iniziato a seguire questi fumetti negli anni Sessanta resta affascinato e spaesato: legato ai «classici» della giovinezza, prova curiosità per le innumerevoli variazioni sul tema. Rispetto ai giovani e giovanissimi che vivono soprattutto la stagione del «multiverso» dei film dalle scenografie sontuose e dagli effetti speciali allo stato dell’arte, rappresenta la memoria storica, il testimone dei vari capitoli Marvel. E chissà come accoglierà le storie in cui Paperino diventa Wolverine, in un incontro di mondi una volta impensabile. «Quando Disney, anni fa, annunciò l’acquisto di Marvel tanti avevano iniziato a immaginare incontri tra Topolino, Paperino e i supereroi» nota Bertuzzi. «Adesso sembra che questi incontri possano essere possibili, incuriosendo altri neolettori. Per il nostro Paese, poi, sono storie particolarmente importanti: i disegni sono infatti firmati da autori e autrici italiani, i più bravi e amati al mondo per i personaggi Disney».